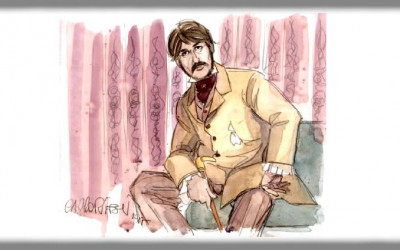Lo si potrebbe definire uno scavezzacollo d’altri tempi, il marchese Francesco Pizzardi, figlio d’illustre famiglia della Bologna dell’ultimo quarto dell’Ottocento, dibattuta tra ansie post-risorgimentali e anelito alla modernità. Una città che, da un lato, era “ancora incastonata nella cerchia delle antiche mura, più tardi vandalicamente abbattuta, ancora intatta nelle sue vie porticate dalle lente curve sinuose, piena di silenzio e di mistero” – come scrisse Giovanni Pascoli agli inizi del Novecento – e dall’altro era attratta dalla modernità della musica wagneriana, tanto da ospitare al Teatro Comunale tra il 1871 e il 1883 ben quattro rappresentazioni del compositore tedesco.
L’élite intellettuale si raccoglieva intorno a Giosuè Carducci e si riuniva nel retrobottega della libreria Zanichelli, sotto il portico del Pavaglione. A portare le moribonde strutture politiche ed economiche dello Stato Pontificio dentro il nuovo assetto istituzionale dello Stato unitario fu il nuovo gruppo dirigente dei Minghetti, Tanari, Berti Pichat, Audinot. Parte rilevante in quella fase ebbe anche Luigi Pizzardi, presidente della Banca popolare, senatore del Regno e “primo sindaco di Bologna libera” dal marzo 1860 all’ottobre 1861. Il nonno Camillo e il padre Gaetano erano stati gli artefici della fortuna della famiglia: i vasti possedimenti terrieri nella pianura bolognese e la partecipazione alla Società per le miniere sulfuree di Romagna procurarono ai Pizzardi ricchezza, il titolo di marchese e la magnifica dimora urbana di via Farini. All’impegno civile e politico che caratterizzò le vite di Gaetano e Luigi Pizzardi si sottrasse il figlio primogenito di quest’ultimo, Francesco, nato nel 1846 e affidato alle cure della nonna materna dopo la morte per parto della madre nel 1852.
A Torino, dove a sedici anni è mandato a studiare per far carriera nell’esercito, Francesco Pizzardi si fa prendere dal vizio del gioco, costringendo il padre a numerosi interventi riparatori. Dopo che nel 1867 il giovane ufficiale ha perso un’ingente somma, il padre ne chiede l’inabilitazione al Tribunale di Bologna per motivo di prodigalità, sentenza poi revocata nel 1873 per “ravvedimento totale”. L’episodio più clamoroso di questa cattiva condotta è del 1869, quando Francesco per una questione di donne uccide in un duello alla pistola il venticinquenne Giuseppe Mazzacorati, amico dell’eroe risorgimentale, politico e scienziato Quirico Filopanti.
Luigi Pizzardi muore nel 1871 senza essere riuscito a domare il suo primogenito, che con i fratelli Carlo Alberto, Camillo e Cesarina eredita una vera fortuna. Degli affari di famiglia si occupa Carlo Alberto: dalla donazione di questi, poco prima di morire, all’Amministrazione degli Ospedali, nascerà nel 1927 il Bellaria “Carlo Alberto Pizzardi”, uno dei quattro ospedali pubblici di Bologna. Francesco, invece, è interessato solo alla caccia e ai viaggi esotici. Il diario epistolare del suo viaggio in India è pubblicato nel volume “Da Bologna all’India. Il viaggio del Signor Marchese Francesco Pizzardi (1877-1878)” edito da Bononia University Press e curato da Angelo Varni.
Indirizzate ai fratelli, e prevalentemente a Camillo, le lettere di Francesco raccontano il viaggio iniziato da Bologna il 13 ottobre 1877 e terminato il 30 maggio 1878 con il ritorno sotto le Due Torri da Alessandria d’Egitto. L’interesse di questo documento sta nella sua aderenza alle idee di un’epoca: il giovane rampollo di una delle famiglie più note e impegnate del liberalismo bolognese, gira il mondo per curiosità, insoddisfazione e forse ribellione allo stesso ambiente da cui proviene. Si legge, nelle lettere di Francesco, l’insofferenza verso gli obblighi di ospitalità, come l’uso di abito da sera e cravatta, dovuti alle autorità inglesi che lo accolgono e gli danno supporto per le battute di caccia. Nondimeno, anche quando avverte le contraddizioni di un sistema che tiene insieme i cinque pasti al giorno degli inglesi e la morte per carestia di milioni di indigeni, non vacilla il suo sentimento di superiorità morale, culturale e razziale nei confronti di questi ultimi. “Tutti gli Hindù coi quali ho parlato sono d’accordo nel confessare che da soli non sarebbero capaci di governarsi, e riconoscono che debbono molto agli Inglesi i quali realmente fanno sforzi inauditi per incivilirli” – scrive. Tuttavia, la curiosità per l’India e i suoi riti è talmente forte da farlo innamorare di questo paese “meraviglioso per tutto ciò che riguarda natura, abitanti, costumi, monumenti, caccia” – anche se ai monumenti non è per nulla interessato, e moltissimo invece alla caccia, che sembra essere la sua prima ragione di vita.
“Io non amo che la caccia”, scrive Francesco. La ama come sport, come spettacolo, e come in fondo ama l’India, cioè per quanto di straordinario, di lontano dalla quotidianità c’è in un’attività in cui può capitare di montare un elefante per cacciare la tigre, inseguire antilopi servendosi di un leopardo bendato, far strage di cervi, braccare rinoceronti. A noi, anime ambientaliste, fa ribrezzo questa disinvoltura nello sparare anche ai tigrotti e nell’annotare il bottino di caccia: “In 13 giorni in 9 persone da principio e in 8 dopo abbiamo ucciso 1 Tigre, 16 Bufali, 122 Cervi, 102 cignali, 10 lepri, 6 florikan, 57 pernici, 2 quaglie, 1 oca e 15 anitre. Totale 317 capi”. In una delle ultime lettere, Pizzardi si lamenta che una certa “campagna è meno selvaggia di quella di Kuch-Bahar. Vi è una quantità enorme di cervi e di cignali, bufali in abbondanza ma poche tigri. Ciò dipende dalla grande strage che ne è stata fatta negli anni scorsi”. Se in questa frase c’è un minimo di consapevolezza della fragilità dell’ecosistema (troppa caccia, niente caccia), prevale sempre la voglia di avventura: sentirsi sballottato nel deserto sopra un elefante, vedere un bufalo pazzo che s’immola per caricare sessanta elefanti, rinunciare a sparare a un pitone per non farsi sentire dalla tigre alla quale si sta tendendo un agguato, far abbattere alberi dagli elefanti per penetrare negli inestricabili boschi del jungle.
Tra una battuta di caccia e l’altra, scorre davanti agli occhi l’India misteriosa. Come la danza rituale delle nautch (ballerine) al matrimonio di un rajah quindicenne vestito come un damerino di Londra: “Finché alcune signore Inglesi (tutti mostri) furono presenti, le nautch furono insulse, ma partite quelle cominciarono un ballo così lascivo, così eccitante da far perdere la testa a un cantore della capella Sistina. E tutto questo con un’aria compunta e modesta come se si vergognassero”.
C’è sgomento davanti alla morte per fame: “Sono rimasto come ebete davanti allo spettacolo di queste povere creature che non hanno più nulla di umano. Immaginatevi degli scheletri rivestiti con una pelle troppo larga; le coscie degli uomini e delle donne non sono più grosse del mio braccio, e gli stinchi non più del mio polso; non vi parlo dei bambini i quali per un’amara ironia della sorte hanno il ventre sviluppatissimo per un’enorme dilatazione del fegato prodotta, io credo, dall’acqua infetta che bevono”.
In un’altra lettera annota: “Accanto a un accampamento Inglese dove regna il confort, dove non si beve che Champagne, dove ogni pasto non ha meno di 10 portate, vi è della gente che mangia erba e sterco e finisce per morire di inanizione. Esci dalla casa di un’Ufficiale Inglese, dove haj pranzato in cravatta bianca, dove le Signore erano decollatées, e passeggi in mezzo a una folla nuda o quasi nuda”.
A Bombay Francesco vede le pire funebri “nel cimitero degli Hindou, ossia nel luogo dove abbruciano i cadaveri. E’ uno spettacolo ributtante. Quando siamo giunti stavano abbruciando 6 cadaveri: il corpo stà fra due strati di legna, ma la testa e le gambe sporgono dal rogo e si vedono le carni abbrustolirsi, e colare il grasso che frigge e ravviva la fiamma”.
Infine, lo spettacolo del Gange a Benares: “E’ un amalgama di sontuosi palazzi di Rajahs e di tempii di tutte le forme e di tutti i colori, immense gradinate scendono da questi fabbricati al fiume, e sui gradini un formicolio continuo di gente che viene a bagnarsi nelle onde del fiume sacro (…). Dove volete trovare un quadro più bello di questo? (…) ciò che dà la vita al quadro sono i vestiari delle donne ed anche degli uomini. Hanno dei colori e soprattutto delle mezze tinte che non si conoscono in Europa. Oltre il rosso vivissimo ed il turchino ed il giallo, vedi a miriadi il verde chiaro, il rosa tenero, il lilla moribondo. La simmetria morirebbe idrofoba se guardasse Benares dal Gange”.
La passione per la caccia porterà ancora in Oriente negli anni successivi Francesco Pizzardi: sappiamo che nel 1883 è a Singapore e in Indonesia. A Bologna ha preso in affitto una residenza in palazzo Montanari di via Galliera, dove conserva la sua collezione di trofei di caccia fino alla morte, avvenuta nel 1919 nella sua abitazione di Montecarlo. Morì tra i debiti il marchese di Bologna per il quale la vita era un’avventura di caccia grossa, dopo la quale ci sarebbe stato soltanto il banale viaggio turistico.