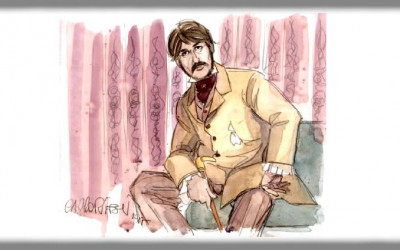Care amiche e cari amici di Radio Emilia-Romagna, la protagonista di oggi è stata una inimitabile creatrice di copricapi femminili, tanto da essere contesa da alcuni dei più grandi stilisti del mondo. Nata nel 1913, Isotta Zerri ha attraversato il secolo breve vivendo tra Bologna e Parigi, ma non ha mai voluto recidere il legame con piazza Santo Stefano, dove le sue idee diventavano pezzi unici destinati a rendere indimenticabili i volti delle donne che li indossavano.
Leggiamo e ascoltiamo insieme il ritratto che a Isotta Zerri ha dedicato la scrittrice Marta Casarini nel libro intitolato “Le donne che fecero l’impresa. Nessun pensiero è mai troppo grande”. Il volume, che raccoglie gli scritti di diverse autrici, è stato curato nel 2016 da Katia Brentani e Lorena Lusetti per le Edizioni del Loggione.
Chapeau
Diverse supposizioni si sono susseguite come conseguenza al mio rifiuto di partire per Parigi.
«È pigra», si è sentito mormorare. «È una donna, ha i suoi doveri da compiere».
«Non è adatta alla ville Lumiére. È signora di provincia, di piccolo mondo».
Quante sciocchezze di gente senza fantasia.
Una non può diventare l’ultimo minuscolo sasso che provoca la slavina, la paillette di troppo che rovina un vestito. Ogni decisione richiede dell’estro e ritengo si debba mantenere una certa eleganza anche nei pettegolezzi. Saperli inventare e saperci sfilare sopra con grazia e leggerezza.
In punta di piedi.
Parigi non l’ho amata mai per davvero. Viali troppo ampi, troppa luce del giorno a illuminare ogni anfratto.
La mia città non è così abituata alla chiarezza. Bologna è più angusta, più adatta alla penombra.
La mia prima volta in Francia, Christian mi portò a visitare gli atelier a Saint Germain; quei guanti di pelle che salutavano dalle vetrine come dame dell’Ottocento dalle carrozze, e scialli impalpabili di seta, minuscole pochette dei più diversi materiali. Metallo, argento, persino leggero, intricato ferro battuto. E i cappelli. Di ogni colore e dimensione.
Bombette di lana bianca e nera, nastri esagerati color turchese, tese squadrate o morbide volute ad accarezzare il viso. Se ne stavano appesi a bave da pesca, dondolando nello spazio dorato delle vetrine, uccelli dalle piume vaporose.
«Questi non sono accessori per signore» dissi a Monsieur Dior, «sono splendidi oggetti da arredamento».
«Nulla che tu non abbia già creato, ma chérie,» mi rispose lui.
Era vero, ed ero in grado di fare anche di meglio.
Sapevo dire la verità.
Imparai da piccola a cucire, e a riconoscere la differenza tra un oggetto ben fatto e la materializzazione di un’idea.
Un oggetto è un oggetto. È fatto di fibra, atomi, qualche ora di duro lavoro. Ha una sua utilità, una ragione d’essere ben precisa e quantificabile.
Un’idea è un’idea, e renderla reale è compiere un piccolo miracolo.
Mia madre e mia zia erano sarte; passavano le giornate nel salotto della grande casa in via Fondazza sepolte da scampoli e modelli disegnati con il gesso sulle veline.
A me piaceva osservarle mentre stringevano gli aghi tra le labbra, a prendere le misure ai fianchi delle signore in visita, che se ne stavano in piedi sullo sgabello a braccia tese, preoccupate di trattenere la pancia. E mi piaceva l’odore dei vestiti appesi alle stampelle. Ogni tipo di stoffa aveva un aroma differente e il mio preferito era quello della lana cotta, utilizzata per rivestire gli stretti copricapi delle nonne. Sapeva di pascolo e tintura, di campagna, di giornata trascorsa all’aperto, e di ovino. Un odore lieve, eppure chiaro, preciso. Mia madre spruzzava la lana cotta di profumo alla violetta, per mascherarne l’aroma. Ma non se ne andava mai via del tutto.
Fu forse proprio per quell’odore che diventai una cappellaia matta, come mi piace ancora definirmi, e fu una delle ragioni per le quali dissi no a Parigi.
Persino quando, trent’anni dopo, mi implorò Coco.
La casa in via Fondazza era rotonda e al suo centro esatto si trovava un cortile interno lussureggiante di alberi di limoni. Li aveva piantati un innamorato di mia zia ai tempi della Campagna d’Africa. Lui era un soldato che aveva fatto carriera e aveva trovato in Abissinia certi semi che, gli aveva giurato – a suo dire – una spia di Menelik, non solo sarebbero sopravvissuti, ma avrebbero addirittura prosperato anche nei gelidi inverni bolognesi. A patto, però, che fosse davvero innamorato della persona alla quale li avrebbe donati.
La spia di Menelik, che lo fosse davvero o no, su tante cose poteva aver mentito, ma non su quella. L’amore per mia zia aveva reso forti i limoni che ogni estate davano frutti succosi e nutrienti, di un giallo abbagliante, nonostante le nevicate, nonostante l’umidità che nella mia città stilla, in certi mesi, dalle pareti. Mia zia ne coglieva qualcuno ogni domenica mattina d’estate e ne utilizzava il succo per preparare il suo famoso plum cake agli agrumi. A me ispirarono il colore solare della mia prima creazione a tesa larga.
E quei limoni furono un altro motivo per cui dissi, a Parigi, di no.
Le guerre mancano, da par loro, di eleganza. Eppure, anche da esse, può nascere la poesia.
Forse proprio dalla rivolta al dolore, al disumano, dal bisogno interiore e insaziabile di aggrapparsi al bello nella tragedia, nell’uomo nasce la smania della creazione.
Io ho sempre pensato molto.
Ho passato la mia vita a immaginare. Anche durante la prima guerra mondiale, e poi nel bel mezzo della seconda, quando le sirene ruggivano come bestie nell’aria della città pesante di fumo, e i rifugi antibomba si riempivano di gambe e fagotti pieni di oggetti alla rinfusa, io progettavo sogni e desideri.
Ho sempre voluto credere che ogni persona, per quanto preda delle bassezze umane, fosse un involucro di idee e aspirazioni.
E le idee, i sogni, i desideri, le aspirazioni nascono dalla testa. È lì che prendono forma. E io li ho vestiti.
È stato detto che le mie creazioni fossero irreali, surreali, importabili per una signora perbene. Troppo audaci, troppo stravaganti, ma cos’è un sogno se non un animale ribelle, dalle proporzioni che sfidano la zoologia?
Tutto nasceva nella mia testa e tutto finiva sulle teste altrui. Dai tempi del charleston a quelli della pop music ho calzato le nuche di attrici e ballerine, prémieres dames della politica e dei salotti borghesi.
Ho guardato, passeggiato, e poi mi sono punta le dita e rovinata gli occhi a forza di infilare crune e scegliere tessuti che si adattassero alle mie fantasie.
A Madamoiselle Chanel piacevano di me gli occhi, l’audacia e l’uso disinvolto delle piume.
A Christian Dior la disinvoltura con la quale vestivo le idee di Gina Lollobrigida e giovani studentesse universitarie, e tutte con la stessa grazia e la stessa cura, senza fare distinzione.
Ogni testa è importante e va valorizzato ogni seme di intuizione.
L’ispirazione scaturiva, sì dai limoni del giardino in via Fondazza, ma anche dal sole che se ne andava a dormire piano dietro i colli fuori dalle mura, e dal pavimento scomodo ai tacchi di Piazza Nettuno, dove la sera spazza le malinconie del giorno.
Venivano, le mie ispirazioni, dalla chiesa spoglia di Santo Stefano. Dalla sesta volta a ogiva del portico a sinistra della chiesa, dove mio marito mi chiese di sposarlo. Dalle insegne robuste delle osterie, dai profumi domenicali di carne brasata negli androni dei palazzi. Dai passi dimenticati dietro la stazione dei treni. Le mie creazioni erano così diverse dagli evanescenti oggetti negli atelier parigini. Erano pascoli e umidità con sogni di metropoli.
Bologna, io l’ho vista cambiare attraverso un secolo di famiglie e di idee.
Non potevo fare altrimenti, non potevo altrove. Le mie forme, i colori, i bottoni, i nastri, gli orpelli.
Non esistono altri luoghi per un’artista se non quelli in cui nasce e cresce.
Quei luoghi diventano tutto il mondo.
Non manca la curiosità del viaggio, lo stupore dell’esotico, del lontano.
Ma a cosa serve, davvero, andarsene, se le idee, l’artista, le trova dappertutto? Se ne riconosce le radici in se stesso.
Bologna mi è bastata per avere successo e dita sanguinanti.
Mi è bastata anche se piccola, di provincia, mi è bastata anche se donna.
Perché la passione che le ho riservato è stata la stessa che ho donato ai miei cappelli.
Gioiosi, sinceri, pazzi e ricchi di sapore come limoni trapiantati per amore, che prosperano meravigliosi in un luogo inaspettato.
[testo tratto dal libro: “Le donne che fecero l’impresa. Nessun pensiero è mai troppo grande”, a cura di Katia Brentani e Lorena Lusetti, Modena, Edizioni del Loggione, 2016. Autrici: Fosca Andraghetti, Katia Brentani, Marta Casarini, Carla Cenacchi Bacchelli, Maria Genovese, Sabrina Leonelli, Lorena Lusetti, Sara Magnoli, Cristina Orlandi, Francesca Panzacchi, Alba Piolanti, Rosalba Scaglioni]