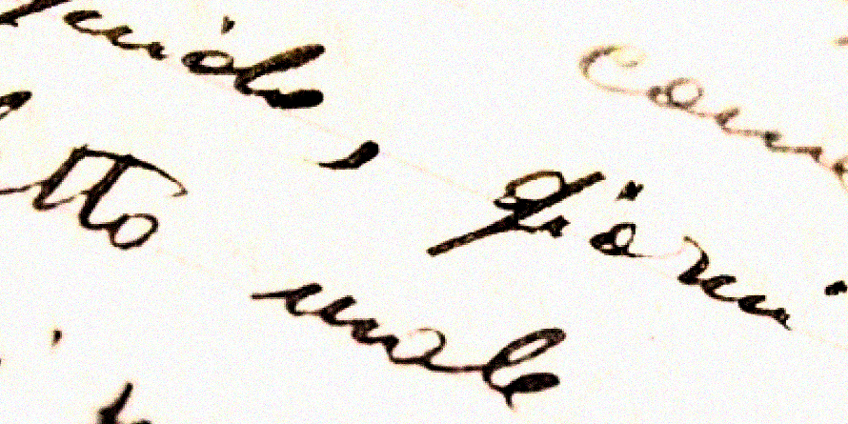Storica e antropologa, Laura Artioli introduce i testi e le immagini delle lettere scritte alla famiglia da una giovane antifascista reggiana durante la sua prigionia tra il febbraio e il luglio del 1944, lettere ora raccolte da Pierluigi Tedeschi.
Dalla sua cella in San Tomaso, Serena individua e sgrana i punti di fuga nella prospettiva, non fosse che attraverso il sonno, quando altro non si trova. Sai alle volte riesco anche alzarmi verso mezzogiorno, scrive a fine maggio alla sorella Stella. Con la quale si concede anche di abbandonare un po’ l’autocontrollo che esercita quando si rivolge ai genitori. Pochissime notti fa ti ho sognata a casa della mamma con i tuoi trè figli, racconta. Immaginarti senza dirtelo, come sarò rimasta nel svegliarmi.
Ma la dialettica del fuori e del dentro che questa ragazza concreta e fattiva sembra praticare quotidianamente per sopravvivere, risulta meno ingannevole dei sogni.
Perché ci sono i legami familiari, affettuosi e centrali nella sua vita, da mantenere attivi, le notizie dei fratelli arrestati da far arrivare a casa, le istruzioni per i colloqui, le raccomandazioni relative ad Avanti [il fratello] – solo pensate per lui e portateci ciò che vi chiede, perché immagino che l’appetito non ci manca –, la felicità degli incontri, per quanto fugaci, con il padre, la Viva, i fratelli Eolo e Sereno. Il timore che gli sfollati – approderanno dai Pergetti a maggio – siano di peso, la sua cameretta invasa, la pena per l’aiuto che è venuto a mancare in famiglia.
Si tratta, sopra ogni altra preoccupazione, di proteggere i poveri nostri vecchi, e la mamma in particolare, dall’ansia per la sorte dei due figli rimasti in carcere.
Che l’arresto della figlia minore sia stato un colpo duro per Cesira Marmiroli, tale da averle provocato un di più di angoscia e qualche dose di riprovazione neppure troppo nascosta, si intuisce forse da una affermazione sibillina del ventisette aprile, mamma hò pure capita la vostra ragione, mi hà un po’ sorpresa, ma avete fatto bene lo stesso a dirmela, così saprò regolarmi.
E a giugno, scrivendo al fratello Guido, afferma: sento ciò che dice la mamma di mè quando verrò a casa, che mi chiuderà a chiave nel solaio.
Con la madre, che era malata il pomeriggio del suo arresto, Serena dispiega raziocinio e leggerezza insieme. Mi sembra di essere a mondariso, le scrive il quindici marzo dal camerone dei Servi, si dorme nelle brande e come mangiare è più buono solo che non c’è libertà, ma verrà presto.
E di nuovo a fine maggio, quando la lontananza si era fatta interminabile, voi mamma spero starete bene, dato che sono del 1922 pensate che sia giovanotto, e che sia militare, perché se ero a casa toccava partire, per la gita che hò fatto l’anno scorso, cioè alla risaia, dunque come vedete non sarei a casa ugualmente.
Intanto scherza sulle compagne, che sono tutte palandrone ed io mi tocca sgobbare dalla mattina alla sera per tener puliti tutti questi mobili!
Da maggio in poi l’incubo dei bombardamenti aggrava le angustie dei suoi cari: Serena non nega di avere paura a sua volta, ma tutto è andato bene, scrive con una certa baldanza, e poi noi donne sotto al rifugio, abbiamo sentito pochissimo, ma non avrei immaginato di avere così tanto coraggio, sebbene fossero quasi tutte moribonde dalla paura.
Al centro del cuore di Serena, l’immagine della sua cara casetta mantiene aperto il fuori – anche solo in assenza – di fronte alle muraglie che la imprigionano.
Sono andata a cercarla, questo febbraio di neve alta come nel 1944, lungo la strada provinciale che collega Sesso a Villa Argine.
La casa dei Pergetti – in un malinconico stato di abbandono –, l’ingresso protetto da una cortina di alberi che si vedono da lontano, è piccola e compatta, con i suoi tre piani e il tetto a quattro acque. Niente rustici intorno, se non un basso servizio che si appoggia sul lato che guarda a mattina.
In mezzo alla campagna, ma non alla larga, i vicini a portata di voce. Quando faceva l’operaia nel calzificio e aveva urgenza di rincasare, Serena tornava in bicicletta dalla città in venti minuti.
La casetta disegnata e costruita da suo padre a misura della loro famiglia di casanti – diversa dai cascinali ampi e ben ripartiti di chi possiede poderi e stalle – è un insieme di abitudini e di sogni che determinano l’essere più vero di Serena, per quanto lontana si trovi. L’uovo, il nido, la patria, l’universo.
Via via che avanza la primavera, la nostalgia delle pareti domestiche si estende al mondo circostante, dove esplode la più giovane delle stagioni della cui perdita nessuno la risarcirà.
Mamma anche quest’anno non vedo il mio giardino fiorito – scrive –, ma spero di venire a vedere almeno le rose fiorite, vi pare? E mentre anche maggio trapassa: chissà che bella campagna ci sarà tutta verde, pensare che qui non si vedono (che) mattoni e mura.
Tornata bambina con i suoi nipoti alle prime avvisaglie d’estate, per due volte Serena scrive al figlio di Eviva [la sorella]: ora caro Ivo, incomincerai frà poco andare dai nonni per vedere se le ciliegie incominciano a venire rosse.
Anche le richieste di cibo che arrivano a casa risentono della stagione, e invece del solito pane le ragazze hanno desiderio di fresco, di appena spuntato, di qualche companatico che sappia di terra lavorata: digli che mi mandino… cipollini qualche cosa insomma da salare di verde.
A metà maggio anche i saluti fioriscono: e coraggio, vi invio 100 bacioni di tulipani.
Pur avancer je tourne sur moi-meme
cyclone par l’immobile habité.
Jean Tardieu
Dentro il perimetro breve della cella, le ragazze combattono l’ozio – il vuoto più spalancato, la croce più devastante per una giovane donna abituata a compartire operosamente le ore della propria vita e ridotta a chiedere alla mamma che le faccia avere un po’ di filo per aggiustare il grembiulone.
L’inattività forzata scatena mali pensieri che hanno a che fare con la sorte e la colpa, sui quali Serena cerca di scherzare: non sò cosa combinerò quando verrò a casa, con questo poltronismo.
Per tenersi insieme e non cedere alla durezza delle circostanze, Serena descrive, richiede e raccoglie frammenti del proprio mondo: già nel primo biglietto uscito clandestinamente dai Servi domanda la cintura quella metà rossa e metà blu di stoffa.
Nei mesi seguenti sarà tutto un andirivieni – fra la sua cameretta e San Tomaso – di ciabatte verdi e di sandali neri aggiustati, della veste a fiori quella delle maniche lunghe, di calzettoni di lana nasella, del sottoveste blu, dell’abito arancione e di quello a bolli, e anche di un asciugamano di colore e delle mutande rosa di seta e della scatolina di pillole Carlo Erba che si trovano nel cassetto del comò. Di sapone e di borotalco.
Si salvano anche così, queste ragazze indome; quando a luglio Lucia uscirà dal carcere, si farà dipingere le unghie di rosso da Dorina.
Preservano sè stesse e il proprio ordine simbolico.
Più si è rinchiuse e più si vagheggia di fidanzati: in men che non si dica, Serena mette in campo una schermaglia amorosa a distanza fra il fratello e una delle sue compagne di cella. Per suo tramite, i due giovani si scambiano ammiccamenti spiritosi: Eolo io ti contraccambio il tuo ovile di baci con un pollaio, ciao Teresa.
Ma intanto la più giovane dei Pergetti si preoccupa di custodire la propria reputazione. Saranno rimasti sorpresi quelli del vicinato sapere del mio arresto, ma non ci stò male, scrive a marzo. Più avanti si stupirà che la notizia sia arrivata fino a Massenzatico, chissà se più impensierita o fiera.
Sta di fatto che, com’era nel destino e nell’ordine naturale delle cose, a guerra appena finita Serena sposerà il partigiano Vito – Decimo Formentini –, che era stato in montagna con suo fratello. E abiterà con il marito nel solaio di casa Pergetti.
Valorose e lucide, le giovani donne di quella primavera in San Tomaso vincono la loro guerriglia di resistenza alla galera.
Per quali vie e a che prezzo abbiano poi rielaborato fra sé l’esperienza cruda e abietta della detenzione e fatto fronte al sottile biasimo sociale che ne derivava, non ci è dato sapere.
Nell’unico memoriale che redige nel 1965, Lucia Sarzi sembra attraversare gli anni della guerra con la levità di una farfalla. Come se il carcere le avesse fornito soprattutto l’occasione di ritrovare le compagne di lotta e incontrarne di nuove.
Ancora più tardi – nel 1971 – Serena racconterà: per 60 giorni restammo rinchiuse in quella stanza con pidocchi e cimici e per 30 giorni non ci lasciarono mai uscire, neanche per soddisfare i bisogni fisiologici. Siccome al centro della stanza c’era un mucchio di carta, si faceva come i gatti. Malgrado gli odori e i gas, avevamo ugualmente il coraggio di cantare le canzoni partigiane che ci insegnava Lucia. Si è pianto anche, ma la soddisfazione di vederci a piangere ai fascisti non l’abbiamo mai data.