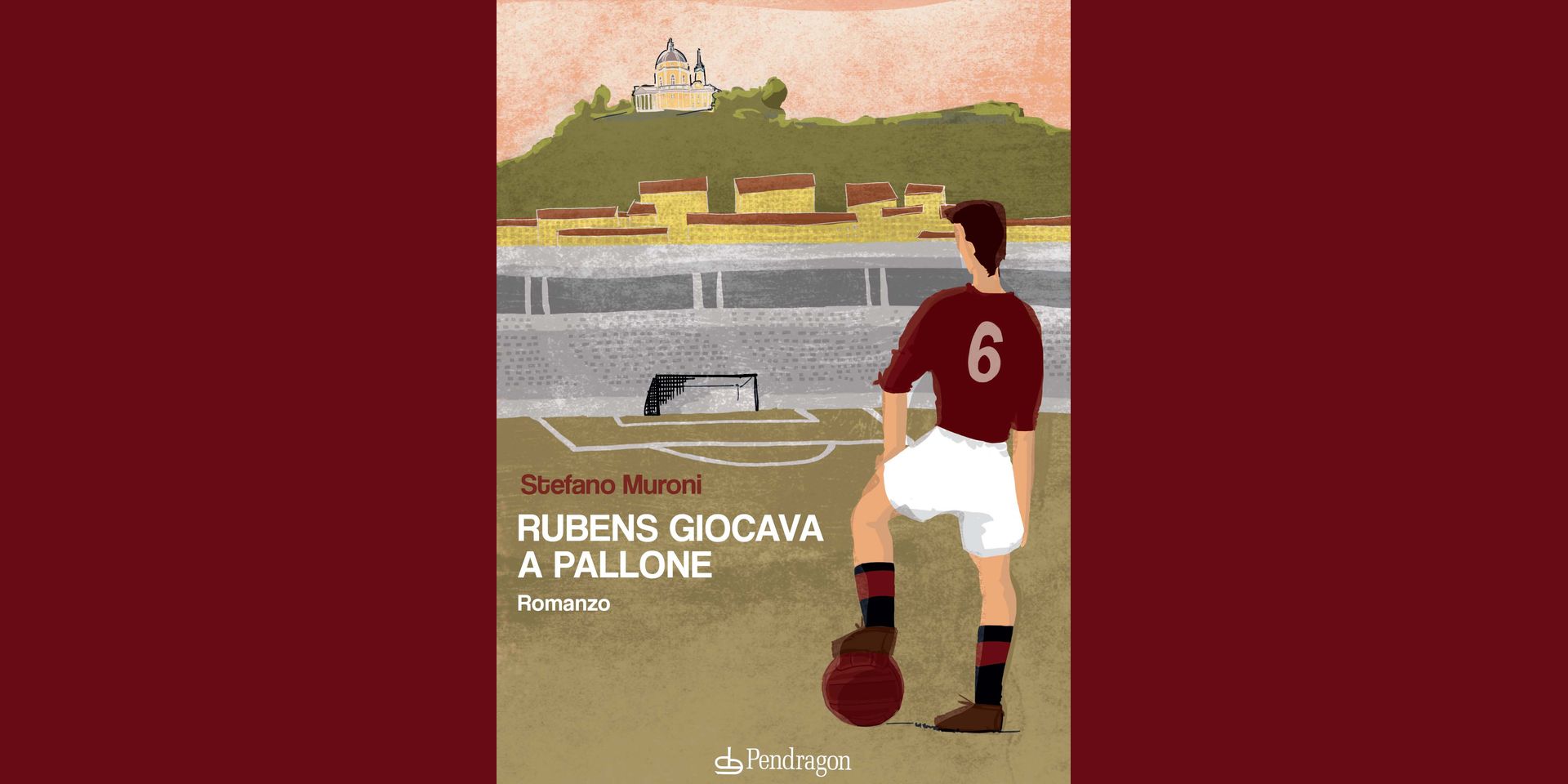Rubens Fadini, campione in erba del Grande Torino, fu la vittima più giovane della tragedia di Superga, in cui perse la vita con l’intera squadra granata. Lo scrittore e attore Stefano Muroni rievoca la sua vicenda in un romanzo storico che affonda le radici nelle terre basse della grande bonifica ferrarese, là dove il calciatore nacque. Ringraziamo per la lettura Francesco Angelelli e l’associazione “Legg’io”.
Un giornalista chiese alla teologa tedesca Dorothee Sölle:
«Come spiegherebbe a un bambino che cosa è la felicità?».
«Non glielo spiegherei» rispose.
«Gli darei un pallone per farlo giocare».
Eduardo Galeano
Pensare che di lui non ci sia rimasto più niente, questo fa male.
Né una camicia, un paio di pantaloni, o il barattolo della brillantina che adoperava ogni mattina per prepararsi. Né una lettera scritta prima della fine di tutto. Anche una foto in più – a parte quelle in posa, di rito, prima di ogni battaglia – per vederlo in altre situazioni: che so, quando era in campagna da bambino, o la prima comunione, oppure quando divenne operaio alla Ceretti, o una foto con gli amici, quando già guadagnava bene. Non una cintura, un pacchetto di sigarette. Neanche la casacca del Tresigallo Calcio che usava durante gli ultimi allenamenti in bonifica, nei freddi mesi del 1944, quando era ritornato al Cimabue per scampare dai bombardamenti su Milano.
Un suo pensiero di vita, un suo concetto, un suo modo di dire.
Nemmeno una registrazione della sua voce è rimasta.
È scomparso tutto – di lui non resta niente – e nemmeno ce ne siamo accorti. Forse un parente da qualche parte nel Nord Italia ancora c’è rimasto.
D’altronde aveva una sorella e molti fratelli. Questi certamente avranno vissuto più a lungo, avranno portato più avanti il loro filò su questa terra, magari innamorandosi di qualche brava ragazza o giovane signorino, dando vita a qualche figlio, tirando su famiglia e lavorando sodo in qualche fabbrichetta di Milano – perché alla fine i Fadini hanno sempre bazzicato Milano e dintorni, mai Torino. E chissà se a quei figli – i nipoti di quel sognatore – avranno raccontato tutta la storia, da cima a fondo.
Dal paese di origine al tesoro scoperto dal nonno. Da quella ricchezza improvvisa fino alla miseria più nera, che costrinse il vecchio Angelo, suo padre, a trasferirsi in bonifica, per cercare un posto qua e là, fra una corte e l’altra, a qualsiasi prezzo e a qualsiasi condizione, pur di racimolare qualcosa a fine giornata, e garantire un pasto caldo alla moglie, alla sorella, e a quei sei figli che, fra il 1918 e il 1927, avevano fatto la loro comparsa in questo mondo marcio.
[…]
Così il tempo passava e quel bruchetto dai polpacci dorati si ingrandiva sempre più. In maniera sempre omogenea, proporzionata, però sempre con un piccolo sbilanciamento verso la parte inferiore. Per capirci: se le braccia, il collo e le spalle crescevano ogni due settimane, cosce, polpacci, piedi e tutte le gambe pareva crescessero giorno dopo giorno.
La madre era preoccupata. «Angelo, non è che ci viene su un mostro, un fenomeno da circo?».
«Ma quale mostro e fenomeno da circo… Annetta, nostro figlio è normalissimo, e sai che facciamo? Viene con me in campagna, lo faccio lavorare solo di braccia, vedrai che lo raddrizziamo».
E dal 1931 al 1933, quando il bambino aveva tra i quattro e i sei anni, passava molte giornate col padre.
La mattina presto lo caricava sulla carriola e lo portava in bonifica.
«Da oggi questo è un lavoratore come noi, ci darà una mano» disse il contadino agli amici contadini. «Si chiama Rubens».
E tutti lo accolsero a battimani, con sorrisi. Lo presero da sotto e lo lanciarono su e giù, su e giù tra la terra e il cielo, come se avesse vinto qualcosa di importante. Divenne così la mascotte di quella squadra di lavoratori, i quali ogni cinque minuti gli chiedevano se aveva bisogno di qualcosa, se aveva sete, se aveva fame. Qualcosa la faceva pure lui, per carità. Ad esempio, quando c’era da raccogliere il fieno, lui ne prendeva un mazzo e lo portava verso i covoni. Oppure quando bisognava andare a spigolare il granoturco: metteva tra le braccia a mo’ di catino tutte le pannocchie che poteva, per portarle poi sopra il carretto del fattore.
«Ma non è troppo giovane questo contadino?» domandava il fattore di turno al Fadini.
«Sì, sì, signor fattore. Ma a lui piace la campagna, ci fa solo compagnia» si giustificava il padre.
E ogni qual volta che tornava a casa la sera, stanco e stracco, chiamava la moglie con il metro da sarta per misurare i miglioramenti dell’addome, dell’apertura delle spalle, della muscolatura delle braccia. Per carità, qualche miglioramento c’era stato. Ma come s’erano ingrossate le braccia, pure le gambe s’erano gonfiate.
«Tesoro, ma quello del contadino è un lavoro completo, ti fa tutto il corpo, è ovvio che sforza anche le gambe se lavora» aveva constatato la moglie.
«E che devo mettergli, un carrozzino sulle gambe e farlo lavorare solo di braccia? Lì sì che viene davvero il circo a prendercelo!» aveva sentenziato il padre, divertito, ma deluso e amareggiato.
Quando una mattina, il vecchio Fadini provò vera paura.
Era l’ottobre del 1933. Da lì a pochi giorni sarebbe iniziata la scuola. E il padre assieme al bambino s’era diretto a piedi verso l’edifico delle elementari. Non lo portò in paese, a Jolanda: troppo lontano e troppi figli di papà – sempre contadini, ma di paese, tutti con la puzza sotto il naso. Lui voleva che crescesse assieme ai suoi, a quelli come lui, i poveri per davvero, agli ultimi, perché tanto ultimi sarebbero rimasti anche dopo, dunque poche speranze, se il buon Dio li aveva messi lì, lì dovevano rimanere, fino alla fine dei tempi, fino al prossimo giudizio universale.
La strada era lunga e tortuosa: c’era da percorrere tutta la via fino al Paleocapa, poi girare a destra e passare per il paese, andare dietro ai grandi magazzini della bonifica, ripiegare su una stradella di ghiaia dove nel frattempo si incontravano cinque-sei possessioni, infine si doveva oltrepassare la strada nuova che stavano costruendo – legava Tresigallo a Jolanda – per poi imboccare l’ultima capezzagna anch’essa ghiaiata la quale portava proprio faccia a faccia col portone d’ingresso della scuoletta gialla – scuola elementare per i figli dei contadini della bonifica, possessione Serraro.
«Mio figlio ha sei anni, vorrei che almeno prendesse la quinta elementare, quando può iniziare?».
Allora la bidella, che era pure segretaria della scuola, e custode e giardiniera, informò il padre del giorno dell’inizio delle lezioni, gli fece firmare qualche carta, e poi se ne uscì.
Ma Rubens non c’era più. Scomparso.
Non all’entrata della scuola, nemmeno in giardino, neppure all’imbocco della stradetta che portava verso casa.
«Avete visto un bambino? È mio figlio…» domandava il padre alla bidella, ma nulla.
Non è che al tempo ci fossero paure di rapimenti o cose del genere. Lì si conoscevano tutti, e nessuno avrebbe mai fatto male a un bambino. Ma la natura brada, irreggimentata dall’uomo, da una parte aveva portato fertilità e donava frutti buoni, d’altra parte fagocitava e inghiottiva i cristiani. Non di rado si sentiva di qualche bambino annegato in un canale di scolo, o qualche bambina caduta in un pozzo e rinvenuta dopo giorni, morta per soffocamento.
La bonifica era come una madre per quei figli di palude, e come le madri, a volte, poteva punire.
Ma quando il pensiero stava sfiorando la tragedia, ecco all’orizzonte – dalla parte posteriore della scuola, un campo dove i bambini trascorrevano l’intervallo – apparire un bambino con ai piedi un pallone.
«Rubens!» urlò il padre.
Ma fu un urlo inghiottito, che sentì solo lui, solo la parte più buona della sua anima. Anima nobile, in fondo, che si sarebbe uccisa pur di non illudere i propri figli.
Il bambino, sicuro che il padre stesse ancora dentro per le carte, s’era messo a gironzolare per il giardino della scuola, ed era andato anche dietro, dove aveva scovato un campo, con due porte di legno e un pallone di cuoio rovinato. E nell’attesa s’era messo a giocare.
E in quel gioco non c’era nulla di fanciullesco, niente di amatoriale, poco di immaturo. Correva, scattava, palleggiava la palla tra un piede e l’altro, l’alzava e la faceva ricadere sul collo, mettendosi a testa in giù. Poi ripartiva, passava la palla a un amico immaginario, faceva una piroetta su se stesso e la riprendeva. Infine calciava verso la porta. Un tiro perfetto, ad arco, che andava a colpire l’incrocio dei pali e cadeva in rete.
Il padre non aveva mai visto nulla di simile. Certo, qualche partita al campo dei Palazzi, verso Tresigallo, dove giocava la squadra amatori, l’aveva vista. Qualche partita alla radio della locanda del paese l’aveva pure sentita. Ma quello che stava vedendo era qualcosa di nuovo, di grande, di importante.
Così, da uomo rude della Bassa, interruppe quella danza, prese il bambino per il braccio e gli diede una sacrosanta sculacciata, apostrofandolo come un bambino cattivo che scappa dai genitori. E poi altre sberle, soprattutto nelle gambe, quasi volesse sradicargli quel suo innato talento.
«Non farlo mai più» urlò il padre, mentre Rubens piangeva e si allungava verso il pallone, verso quel campetto di calcio che era sempre più lontano.
«Perché Rubens non ha voluto mangiare? E perché ha tutte le gambe rosse?» aveva chiesto la moglie, irritata, prima di dormire al marito, la sera stessa.
«Io sono il padre e lo educo come voglio» aveva bofonchiato il marito.
«Tu sarai il padre ma io sono la madre» s’era alzata la donna. «Dimmi subito cosa hai fatto a mio figlio».
Le donne non è che avessero voce in capitolo in quella società, ma in casa, se si inarcavano, non le fermava nessuno. E l’uomo dovette rispondere, mettendo da parte l’orgoglio ferito di maschio: «Mi è scappato. Mi ha fatto preoccupare e gli ho fatto capire che non deve più farlo. Ho fatto male?» aveva domandato, consapevole che aveva tralasciato qualcosa della storia.
«Se è così, hai fatto bene» aveva alzato le spalle la mamma. «Ma non toccarlo più».
E così i due s’erano messi a dormire. Rubens no.
Rubens ancora un po’ piagnucolava dal dolore. Ma non era quello il motivo per cui non dormiva. Lui se ne stava affacciato alla finestra della sua cameretta – dormiva con la sorella e i quattro fratelli – per guardare fuori.
«Mostriciattolo, chiudi che entra il freddo» gli aveva imposto il fratello. Ormai lui era diventato “mostriciattolo” per loro, tanto sproporzionato era il suo fisico.
«Ancora un minuto» pregava il bambino.
Era ottobre, la guerra era ancora lontana e nessuno ci pensava. Là si stava bene, nonostante il fascismo. Fascismo, poi. Anche se ci fosse stata una sorta di democrazia, là si era comunque dentro una Società, dunque sotto padroni, gente che comandava, e le cose forse non sarebbero state poi così diverse. Il cibo c’era, non molto ma era sufficiente. I bambini crescevano bene e le madri partorivano affiancate sempre da una levatrice o da un medico. Il guadagno dei padri era misero, ma mai nessuno, a memoria degli ultimi superstiti di quell’epoca irripetibile, era morto di fame. Tutto insomma poteva andare avanti così. Anche per i fratelli e le sorelle del bambino. Anche per i figli che avrebbero avuto, e per i figli dei loro figli.
Eppure, a volte, qualcosa di inspiegabile e innato si insidia dentro le vene e le viscere delle persone, e dona una diversa prospettiva delle cose, una visione primordiale e mitica dell’esistenza. E nel cuore di quel bambino di appena sei anni pulsava un’energia nuova e vigorosa, che poco c’entrava con quel mondo arcaico della piana. Mentre la luna era tonda e le stelle illuminavano la campagna, e tutte le corti erano nere – non c’era ancora la luce elettrica – un lume restava accesso, in lontananza.
Era quello della scuola elementare, corte Serraro, con dietro il campo da calcio, che dal Cimabue, dalla sua finestrella, si intravedeva. E quel lume laggiù in fondo pareva illuminasse gli occhi accesi di quel piccolo sognatore, che già pensava al primo giorno di scuola, quando avrebbe potuto riprendere a calci il pallone, e percepire di nuovo quella straordinaria sensazione di sentirsi alla pari con se stessi, in una vita che ti voleva sempre in debito.
—————————————————-
Immagini
Particolare della copertina del libro di Stefano Muroni “Rubens giocava a pallone” (Bologna, Pendragon, 2021)
Musiche
Taj Mahal – “Bye & Bye”
Extraliscio – “Dolore”
Francesco De Gregori – “La leva calcistica della classe ’68”
2 Dicembre 2021
| Racconti d'autore
Rubens giocava a pallone
Testo tratto dal romanzo omonimo di Stefano Muroni (Bologna, Pendragon, 2021)
Vittorio Ferorelli