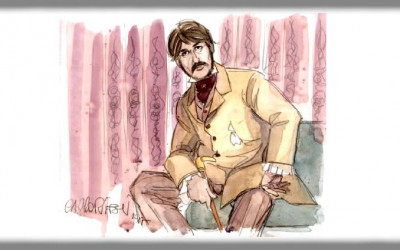Care amiche e cari amici di RadioEmiliaRomagna, la protagonista di cui oggi vi narriamo la storia detestava la retorica ufficiale. Si può supporre, senza andare molto lontani dal vero, che non avrebbe gradito di essere trattata come un simbolo, neanche in occasione di una festa come quella odierna, dedicata alle donne e alla loro capacità di resilienza. Si può supporre che, piuttosto, avrebbe preferito essere raccontata come una donna che ha saputo vivere la sua vita nonostante le difficoltà e le insensatezze della storia, e come tale tenteremo di renderle omaggio a partire dal libro in cui ha riassunto la prima parte della sua vita.
Gina Negrini nasce il 25 agosto 1925, in via Sant’Apollonia, una stradina nel cuore di San Vitale, un quartiere popolare del centro storico di Bologna. “Sporco e decrepito”, come ricorderà a distanza di anni, “litigioso e sfottente e, nonostante gli stracci, allegro dell’amara allegria della miseria”. Fin da piccola dimostra di avere un carattere deciso e poco disposto alle mezze misure. Abbandonata dal padre, è sua madre a tirarla su come può, nonostante la povertà e i periodici ricoveri in sanatorio causati dalla tubercolosi. Quando la bambina ha sette anni, suo malgrado, è costretta a mandarla in un collegio femminile.
Dopo una burrascosa “cattività” durata un quinquennio, non ancora quattordicenne, Gina trova lavoro nella fabbrica dove è impiegata anche sua madre. Producono astucci per gioielli: un ambiente malsano, avvelenato dalle esalazioni delle colle e dalle angherie della padrona. La ragazza ha lasciato la scuola prima del tempo, ma, appena riesce, utilizzando i suoi risparmi, prende a noleggio dei libri da una biblioteca circolante. Ama le storie di avventura e di rivalsa raccontate da Puskin, Kipling e Salgàri, adora le ricostruzioni storiche di Victor Hugo, così piene di passione, ma non si fa alcun problema a mescolarle con le passioni più semplici e immediate di un’autrice “per sole donne” come Liala.
È cresciuta in fretta la bambina di via Sant’Apollonia ma, anche come giovane donna, è costretta a dimenticare la spensieratezza. C’è un padre che si rifà vivo dopo anni di assenza e tenta di abusarla. E poi c’è la guerra, con i suoi piccoli e grandi orrori quotidiani. Quando un bombardamento sulla stazione di Bologna devasta un treno carico di cibo in scatola per il fronte e la gente affamata si riversa sui binari per portar via qualcosa, la polizia spara a vista. A terra, uccisa, rimane una giovanissima operaia che lavora con Gina. È come una scossa di terremoto: “Per la prima volta pensai agli altri”, racconterà. “Mi resi finalmente conto di non avere il monopolio di tutte le disgrazie. Anche chi mi stava attorno soffriva come me e più di me. E moriva!”. Se già da tempo sopportava male una società che faceva propri dei principi che la umiliavano come donna e come essere umano, ora l’insofferenza covata dentro lascia il posto alla rivolta aperta.
Dopo l’armistizio firmato con gli anglomericani l’8 settembre 1943 e l’inizio della guerra civile, la diciottenne Gina Negrini si unisce ai partigiani della brigata comandata da Aroldo Tolomelli. Il nome in codice che le viene assegnato è “Tito”. Scamperà per due volte a una morte che sembrava certa. La prima nell’ottobre del 1944, vicino a Castelmaggiore, quando la casa colonica in cui si trova insieme ai suoi compagni viene circondata da fascisti e tedeschi; esce indenne dalla strage. La seconda a pochi giorni dalla fine della guerra, ai primi di aprile del 1945: questa volta è da sola e sta battendo a macchina gli ordini di insurrezione per tutte le brigate della città in un appartamento che si trova a pochi metri dalla questura. Viene catturata dalle brigate nere, picchiata e incarcerata. Nonostante le minacce e i maltrattamenti, non parla, tiene duro. A risparmiarle la vita è solo la fuga precipitosa dei fascisti dalla città ormai liberata.
Nei primi mesi di libertà, Gina accusa il colpo degli stenti sopportati, a cui si aggiunge il peso della disillusione che, come lei, sperimentano molti altri protagonisti della resistenza. Viene ricoverata in una casa di cura per una pleurite, ma qui l’attende qualcosa di inaspettato. Sono gli occhi orientali e il sorriso timido di un ragazzo azerbaigiano, anche lui convalescente. Si chiama Nuri Alìev, ha fatto parte dell’Armata Rossa, è stato prigioniero dei tedeschi, ne è sfuggito e ha continuato a combattere con i partigiani italiani. I due scampati all’odissea della guerra si riconoscono e si innamorano. Lui vuole tornare nella sua terra, lei decide di accompagnarlo: vuole lasciarsi alle spalle un’Italia che sente ogni giorno più estranea al paese che aveva sognato di costruire con le sue lotte. Un’Italia opportunista, in cui tutti, a cose fatte, si scoprono antifascisti.
Ma il consolato dell’Unione Sovietica si oppone alle loro intenzioni: chi appartiene alla patria del comunismo, viene detto, non può sposare la cittadina di un altro paese. I due insistono, sposandosi a tempo di record e ripresentandosi coniugati al consolato, che prende tempo e mette al loro fianco un ufficiale dell’esercito russo: li accompagnerà nel viaggio verso l’URSS. Una guida ambigua, che una volta varcato il confine si rivelerà per quello che è. Arrivati a San Valentino di Linz, in Austria, i due ragazzi vengono chiusi in un campo di concentramento sovietico. Quando Gina mostra i documenti che attestano la loro partecipazione attiva alla resistenza contro i nazifascisti, il comandante del campo, sotto una grande foto di Stalin, li strappa davanti ai suoi occhi. Lei è costretta a rimpatriare, mentre Nuri viene arrestato: la sua colpa è non essere morto in combattimento ed essersi lasciato fare prigioniero dai tedeschi, senza togliersi la vita “come avrebbe fatto un vero soldato sovietico”.
Da quel giorno del 1946 Gina Negrini non ha più saputo nulla di Nuri, se non un messaggio in cui le diceva di trovarsi in Siberia e che avrebbe fatto di tutto per unirsi di nuovo a lei. Tornata a Bologna, ha vissuto, nonostante il dolore. La sua antica passione per i libri l’ha portata a diventare una bibliotecaria, la sua forza creativa l’ha portata ad esprimersi nell’arte di narrare storie e dipingere immagini. Alla fine degli anni Novanta tenta ancora di rintracciare Nuri attraverso la trasmissione televisiva “Chi l’ha visto”, ma senza risultati.
Una mattina di maggio del 2014 Gina ha chiuso gli occhi per sempre. Da qualche giorno, forse, quegli occhi così chiari avevano recuperato qualche raggio di luce dei suoi diciotto anni. Grazie all’inchiesta dello storico Mickhail Talalay aveva saputo finalmente che Nuri, dopo l’arresto, era stato prigioniero per dieci anni in un gulag sovietico. Ma era sopravvissuto e, come lei, aveva continuato a vivere. Si era fatto tatuare il suo nome sulle braccia. Quattro lettere, il nome di una donna, urlato in silenzio contro la stupidità degli uomini.
[Le informazioni su cui si basa questa scheda sono tratte dal libro di Gina Negrini “Il sole nero” (Imola, Bacchilega Editore, 1999)]