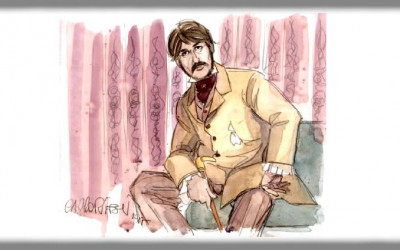“Una vita mirabile”: così il Corriere Padano del 28 giugno 1932 – piena epoca fascista – intitola un articolo dedicato a Luigi Capucci, pioniere italiano in Africa. Prima ancora, era stata “L’Africa Italiana”, bollettino della Società Africana d’Italia, a raccontarne la storia nel numero di gennaio-febbraio 1920, proprio a ridosso della sua morte. Infine nel
L’avventura di Capucci si situa al tempo della prima penetrazione italiana in Etiopia, iniziata nel 1882 con la proclamazione della sovranità su Assab e poi sull’intera Eritrea. Il romagnolo muove i primi passi in Africa nel dicembre 1884, quando giunge ad Assab attratto dal miraggio dei commerci e delle esplorazioni. Ha 27 anni ed è ingegnere. Stessi studi e stessa età dell’amico Cicognani, che finanzia la spedizione. “Che si dice di me a Lugo? – scrive Capucci al padre dalla nave mentre costeggia l’Eritrea -, che sono matto, non è vero? (…) Sono le dieci e mezzo del primo dicembre e voi probabilmente state arrostendovi gli stinchi al fuoco del camino, mentre fuori la brina biancheggia ancora; ed io sono in vista della costa africana, e mi viene voglia di togliermi la giubba perché ho caldo”.
Nel settembre 1885 la carovana abbandona la costa, diretta all’interno dello Scioa seguendo la strada da poco aperta da un altro italiano, il conte Pietro Antonelli. Ma qui cominciano le difficoltà: il ras locale, Mohamed Anfari, vuole una cifra esorbitante per lasciarla passare; inoltre la conquista italiana di Massaua complica la situazione. La carovana ritorna alla costa, sotto la minaccia di Anfari di essere confinata lungo le rive di un fiume in mezzo a zanzare e febbri malariche. Finalmente, trovato un accordo con il sultano Anfari, la comitiva italiana giunge nello Scioa, accolta calorosamente dalla colonia italiana lì residente e anche dal re Menelik, al quale Capucci fa dono di un ricco ombrello ricamato offerto dalla Società Africana d’Italia. Tutto sembra andare per il meglio: Cicognani si sistema nella fertile regione di Gherfa, ricca di sale e celebre per i tessuti, dove conta di rifarsi delle spese sostenute, mentre Capucci intrattiene ottimi rapporti con Menelik. Ma di nuovo, le lotte intestine tra gli etiopi scatenano l’inferno e la carovana di Cicognani rimane coinvolta nel saccheggio dei villaggi da parte delle truppe del negus. Il carico di un solo mulo è quanto resta al romagnolo alla fine di questa disgraziata avventura in Abissinia.
Per fortuna Capucci, in qualità di ingegnere, viene incaricato dal negus Menelik di costruire una polveriera. Si mette subito all’opera nonostante il boicottaggio degli assistenti locali. Il 5 giugno 1886 Capucci indirizza questa lettera all’amico: “Caro Cico. Pare proprio che le cose nostre debbano andare sempre male. Oggi quando avevo ormai finito di preparare lo zolfo, mi si è attaccato fuoco alla polveriera. Deve essere stata una favilla portata dal vento e in cinque minuti tutto era in fiamme”. Favilla portata dal vento o tizzone buttato dagli uomini? L’insuccesso, in ogni caso, non irrita Menelik il quale, anzi, chiede a Capucci di costruire un’altra polveriera insieme a un mulino sulle rive del torrente Acachi a qualche ora di cammino da Entotto. Riparte l’entusiasmo. Per due anni Capucci vive in una stamberga e lavora al mulino superando i continui ostacoli posti dai suoi operai per metterlo in cattiva luce presso la corte. L’inaugurazione, nel gennaio 1888, è un tale successo che Capucci rifiuta i soldi offertigli dalla sorella Clelia per rimpatriare. Spera, infatti, di ottenere altre commesse dal negus per costruire mulini. Nell’agosto ’89 torna in Italia con Antonelli per accompagnare la missione etiope per la ratifica del trattato di Uccialli che stabilisce una sorta di protettorato italiano sull’Etiopia. In quell’occasione viene ricevuto dal re e dai ministri italiani, e i concittadini di Lugo, con in testa Cicognani, nel frattempo rientrato, lo festeggiano come un illustre figlio. Questo è l’ultimo incontro tra i due amici perché Cicognani, fiaccato nel fisico per gli strapazzi africani, sarebbe morto nel
Invitato dagli amici a non ripartire, Capucci risponde: “L’Africa mi attira, non saprei più vivere in Italia”. Tornato nello Scioa, assiste alla formazione della colonia italiana in Eritrea ma anche all’intorbidirsi dell’orizzonte politico. Tra Italia ed Etiopia nascono divergenze interpretative sul trattato di Uccialli che portano a frizioni e scontri. Capucci, italiano e insieme personaggio importante della corte di Menelik, si trova preso tra due fuochi. Quando nel 1893 il negus rigetta il trattato, non riconoscendo il protettorato italiano, l’ingegnere romagnolo capisce che le cose si mettono male. Si licenzia allora dalla corte per dedicarsi al commercio del caffè e dei tessuti, facendo viaggiare carovane dallo Scioa all’Harrar e ai paesi galla del sud. La situazione, intanto, precipita verso la guerra. Il negus Menelik osserva con crescente timore le manovre italiane ai confini del suo impero e prepara la risposta militare. Capucci fiuta il pericolo, liquida i propri affari sulla fine del ’94 e avverte il governatore italiano dell’Eritrea della sua decisione di lasciare lo Scioa. Il governo italiano, quando ormai tutti i connazionali se ne sono andati, lo prega di rimanere a presidiare la stazione di Let Marefià e di passare informazioni sulle mosse degli etiopi. Menelik, che sospetta il doppio gioco da parte di Capucci, riesce a intercettare una lettera cifrata affidata dal romagnolo al suo servo lebbroso perché la consegnasse agli ufficiali italiani. Viene perquisita la casa di Capucci e trovato il cifrario con cui comunica al nostro esercito i piani degli etiopi e i loro sistemi di attacco e difesa. Portato davanti al negus, Capucci ammette le sue colpe e viene condannato a morte. La pubblicistica fascista insiste sulla serena accettazione della condanna: “mai si era sentito così fiero di essere italiano”, scrive il Corriere Padano nel citato articolo del 28 giugno 1932.
Menelik però lo grazia e commuta la pena nella reclusione a vita nell’amba di Uorrailù, un luogo sperduto nell’altopiano etiopico. Dopo quattro mesi di prigionia, Capucci tenta la fuga, viene ferito, ripreso e incatenato a una mano e a un piede. In queste condizioni resta per altri lunghissimi diciotto mesi, fino alla liberazione nel gennaio ’97, giunta non con la vittoria italiana, come lui sperava, ma con l’ingloriosa pace seguita alla disastrosa sconfitta italiana di Adua del 1° marzo 1896.
Dalla liberazione alla fine dei suoi giorni, Capucci rimane confinato nell’oblio. In patria fu presto dimenticato perché dopo la sconfitta di Adua venne inscenata una sorta di rimozione collettiva delle colonie africane. Si sa solo che tornò, povero e solo, in Eritrea, trascorrendo gli ultimi anni della sua vita ad Asmara. Solo
Lettura di Fulvio Redeghieri.