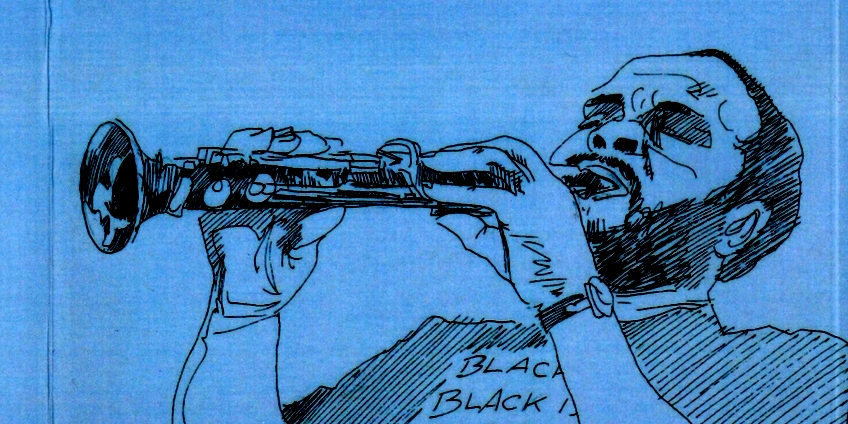Come per ogni passione che si rispetti, la musica jazz non ha bisogno di essere capita, le basta essere sentita. E nelle pagine che le ha dedicato Sergio Pasquandrea ‒ poeta, disegnatore e vero appassionato ‒ si riesce a percepirla tra le righe.
Trenta secondi di pura bellezza
Quando ascolti la musica, dopo che è finita, è andata nell’aria, non puoi più catturarla di nuovo.
Eric Dolphy
Il jazz è musica di attimi. È fatto di illuminazioni fulminee, di bellezza che lampeggia e poi svanisce nel volgere di secondi; o frazioni di secondo. L’importante non è mai il prima o il dopo, ma l’ora. Here and now. To be in the moment è una delle espressioni più usate dai musicisti per descrivere il perfetto stato mentale, quello indispensabile per creare grande musica.
E ci sono momenti, nel jazz, che sembrano condensare la bellezza in dosi quasi insopportabili: la prima nota dell’assolo di Miles Davis su So What, l’inizio del riff in fa minore di A Love Supreme, l’introduzione di Louis Armstrong su West End Blues.
Era il cinque dicembre del cinquantasette.
Sugli schermi americani andava in onda un programma intitolato “The Sound of Jazz”. La rete televisiva CBS aveva messo insieme un cast di giganti: Ben Webster, Lester Young, Gerry Mulligan, Roy Eldrige, Coleman Hawkins, Count Basie, Pee Wee Russell, Thelonious Monk, Mal Waldron. Una sfilata di leggende.
A un certo punto, a circa metà del programma, cominciò a cantare Billie Holiday. Il pezzo era un blues, intitolato Fine and Mellow: uno dei rari blues del repertorio di Billie, grande blues singer che di blues veri e propri non ne cantò quasi mai.
Nella band, tra i sassofonisti, c’era anche Lester Young. Che quel giorno stava male e non avrebbe voluto nemmeno suonare. Aveva quarantotto anni, ma era come se ne avesse avuti cento. Troppa vita, troppa sofferenza, troppa musica, troppa robaccia nelle vene. Billie ne aveva quarantadue, ma non è che cambiasse molto: non aveva più che un filo di voce, la sua arte si era consumata nell’alcool, nella droga, in una vita vissuta senza risparmiarsi niente.
Pare che i due, una volta amici fraterni (qualcuno dice anche amanti), da qualche tempo non si parlassero quasi più.
Ma arriva un momento, dopo il tema cantato da Billie, dopo l’assolo di Ben Webster; un momento in cui Lester Young si alza, raggiunge il microfono e comincia a suonare, ciondolando un po’ da una parte all’altra.
E fa uno degli assolo più belli della sua vita.
Sono poco più di trenta secondi: quattro o cinque frasette blues, semplicissime, elementari. Non più di una cinquantina di note, in tutto. Ma ognuna sembra spremuta dal midollo di un’intera esistenza passata tra il fumo dei locali e il fondo delle bottiglie, ognuna arriva leggermente in ritardo, come se non volesse lasciare lo strumento, cedere il passo alla successiva (il termine tecnico è to lay back, ma da solo dice poco o niente).
E poi, la faccia di Billie. Appena Lester comincia a suonare, lei si volta e lo guarda, inclinando la testa, con una tenerezza da stringere il cuore: socchiude gli occhi, annuisce. Sì, sembra pensare, è sempre lui, è il vecchio Prez. Che cosa sarebbe il mondo, senza quel sax?
È un attimo. Ed è stato definito “il più bell’assolo muto della storia del jazz”.
Poi, appena l’assolo di Lester è finito, Billie ricomincia a cantare…
A tutti e due, Billie e Lester, restava poco da vivere, e forse lo sapevano. Lester Young avrebbe trascorso i suoi ultimi mesi in una stanza, sigillato in un mutismo autistico, senza più suonare, guardando il mondo che passava dietro i vetri, nutrendosi solo di whisky. Morì il quindici marzo del cinquantanove.
Billie lo seguì poco dopo: il trentun maggio dello stesso anno fu ricoverata per una crisi epatica. Un poliziotto stazionava davanti alla sua camera, perché era sotto arresto per possesso di droga, per l’ennesima volta. Se ne andò il diciassette luglio, sola. In banca aveva settanta centesimi, addosso settecentocinquanta dollari in contanti.
Due morti squallide. Eppure basta, da solo, quell’attimo; bastano quei trenta secondi di bellezza abbagliante, a riscattarle di fronte all’eternità.
È tutta questione di attimi.
[“Prez”, che sta per “president of jazz”, è il nomignolo che Billie Holiday aveva coniato per Lester Young. Lui la chiamava “Lady Day”]
————————————————————
Altrove
La musica è la tua esperienza, i tuoi pensieri, la tua saggezza. Se non la vivi, non verrà mai fuori dal tuo strumento.
Charlie Parker
Il concerto più bello della mia vita l’ho visto per caso.
A quei tempi c’era un localino a Perugia dove facevano spesso jam-session (ora credo sia diventato una pizzeria o un disco-pub); io che, beata giovinezza, pensavo ancora di poter essere un decente pianista jazz, ci andavo una sera sì e una pure.
Una sera, o meglio una notte, o meglio ancora un quasi-mattino, uscivo dal locale dopo la jam, intossicato di fumo (allora nei pub si fumava, e io non fumo, fatto che diventa una sciagura quando ci si trova in una stanza satura di fumatori), con gli occhi che lacrimavano per l’aria viziata, con le orecchie rintronate perché il pianoforte era vicino alla batteria, e la batteria era suonata dal feroce Carletto, uno per cui suonare si riduceva sostanzialmente a un’esibizione di forza bruta, e cercavo di scacciare dalle membra l’eccitazione psicomotoria dello swing. Proprio sulla porta del locale notai un manifestino giallo-zabaione e, sapendo che in genere quel tipo di manifesti annunciavano concerti, mi fermai a leggere. E lessi “Benny Golson-Curtis Fuller Quintet”.
Benny Golson e Curtis Fuller sono due nomi di quelli che nelle storie del jazz passano sempre un po’ in secondo piano, inseriti magari in una nota a piè di pagina o in un paragrafo dove si parla di altro. Però un appassionato rizza subito le orecchie.
Benny Golson è un sassofonista, ma è soprattutto uno dei più raffinati compositori e arrangiatori del jazz di tutti i tempi. Talmente bravo che negli anni Sessanta e Settanta capì che poteva guadagnare molto meglio lavorando per la TV, e infatti scrisse un’infinità di colonne sonore per serie storiche come “M.A.S.H.”, “Ironside” e “L’uomo da sei milioni di dollari”. Ma, a parte questo, ha suonato con tutti i grandi, tra il 1959 e il 1962 ha codiretto con Art Farmer il “Jazztet”, uno smagliante combo che faceva un hardbop di inarrivabile perfezione formale, e ha scritto temi ormai entrati nel repertorio di tutti i jazzisti: Killer Joe, Along Came Betty, Whisper Not, Stablemates.
Curtis Fuller, trombonista, per tutta la vita ha fatto quasi sempre il sideman, ma accidenti che sideman: il suo nome compare su dis chi di Miles Davis, di John Coltrane, dei Jazz Messengers, di Dizzy Gillespie. Un vero maestro del suo strumento, che fra l’altro è uno dei più ardui e ingrati fra quelli usati nel jazz.
Gli altri membri del quintetto erano Mulgrew Miller, un ottimo pianista mainstream che avevo già avuto modo di apprezzare su disco; Buster Williams, un contrabbassista per il quale si farebbe prima a dire con chi non ha suonato; e Carl Allen, un batterista che mi pareva di aver sentito nominare ma del quale non riuscivo a ricordare niente di preciso.
Insomma, mi aspettavo un concerto di due vecchie glorie (sia Golson sia Fuller andavano ormai per la settantina), accompagnati da un gruppo di buon livello. Presi nota della data, che era un paio di giorni dopo, e me ne andai a letto.
La sera del concerto il locale era pieno, ma non pienissimo, anche perché, per ragioni misteriose, l’evento non era stato quasi pubblicizzato, a parte qualche manifesto attaccato qua e là per il centro di Perugia. Il pubblico era composto soprattutto di habitués, oltre a qualche appassionato al quale doveva essere giunta voce dell’esibizione.
I musicisti entrarono, e la prima cosa che mi colpì fu che sia Golson sia Fuller dimostravano almeno quindici anni meno di quanto mi aspettassi. Golson, in particolare, era dritto come una quercia, con una folta chioma di capelli ancora nerissimi, insomma poteva passare tranquillamente per un cinquantenne in buona forma. Fuller aveva un’aria distinta da gentleman. Mulgrew Miller sistemò la sua mole colossale su uno sgabello che sembrava dover cedere da un momento all’altro, mentre Buster Williams e Carl Allen salirono sul palco continuando a chiacchierare e ridacchiare, come se stessero finendo di raccontarsi una barzelletta.
Il tempo di accordare gli strumenti e il concerto cominciò. E io capii di aver sbagliato clamorosamente aspettative.
Ho scritto “il concerto più bello della mia vita”, ma mi accorgo di aver usato la frase sbagliata, perché di concerti belli ne ho visti tanti, forse anche più belli di quello. Diciamo dunque che durante quel concerto provai, con un’intensità che è rimasta ineguagliata, la sensazione di essere altrove. In un altro tempo e in un altro spazio.
Non so, avrei potuto essere a New York nei primi anni Cinquanta. Fuori, invece che i sonnacchiosi vicoli medievali del centro storico di Perugia, ci poteva essere una di quelle stradine anonime e un po’ losche che a New York si aprono nel fianco delle Streets o delle Avenues più famose. Quelli seduti al bar non erano i soliti tizi con i quali, ogni sera, cercavo affannosamente di stare sul tempo e di non cannare qualche accordo, ma Miles Davis o Charlie Parker passati per farsi un drink e salutare gli amici.
E quello che stava succedendo sul palco, a pochi passi da me, era (non so in quale altro modo dirlo) IL JAZZ. Quello autentico, intendo, non il volenteroso tentativo che noi cercavamo di cavare fuori dai nostri poveri strumenti, ma quello fatto da gente per cui suonarlo era naturale come infilarsi un calzino o lavarsi i denti la mattina.
Quei musicisti stavano parlando la loro lingua. Di più: stavano parlando della loro vita.
Purtroppo non ricordo molto del concerto: ne ho conservato qualche flash, qualche immagine isolata, e poco più.
Ricordo le manone nere di Mulgrew Miller che scivolavano sui tasti dando l’impressione di sfiorarli appena, ricordo la sua fenomenale introduzione in piano solo a Rhythm-A-Ning. Ricordo la faccia di Nicola, il mio amico pianista, e ricordo di aver pensato che avrei dato volentieri un braccio per suonare così. Ricordo Carl Allen che faceva un assolo usando solo il tom e il rullante, e ricordo come scivolava fuori e dentro il tempo, lo stirava, lo accorciava, ci giocava intorno come un gatto che aspetta di sferrare al topo il colpo mortale.
Ricordo che a un certo punto Benny Golson cominciò a parlare di Clifford Brown e fra le altre cose disse che dalla sua bocca non aveva mai sentito uscire una parola cattiva nei confronti di nessuno, e poi attaccò, da solo, I Remember Clifford, la bellissima ballad che aveva composto nel 1956, subito dopo aver saputo che il grande, l’immenso Clifford era morto in un incidente d’auto, a venticinque anni.
E ricordo che sulla porta incrociammo Mulgrew Miller che con un vocione cavernoso e un sorriso timido ci disse, in italiano, “permesso?”, e io, che sono alto uno e ottantanove, gli arrivavo a malapena all’altezza del naso.
Dopo il concerto ci fermammo a fare capannello fuori del locale, innalzando nuvolette di vapore nel gelo della notte perugina. Tutti avevamo gli occhi lucidi, come un po’ ebbri, e i sorrisi che andavano da un orecchio all’altro.
“Ragazzi”, disse Daniele, il contrabbassista. “Ma l’avevate mai sentito un concerto così?”.
“No, mai”, risposi io. “Questi qui sono quelli veri”.
Probabilmente fu allora che decisi. Non avrei mai fatto il pianista jazz.